La vita da grandi (2025) - Recensione psicologica
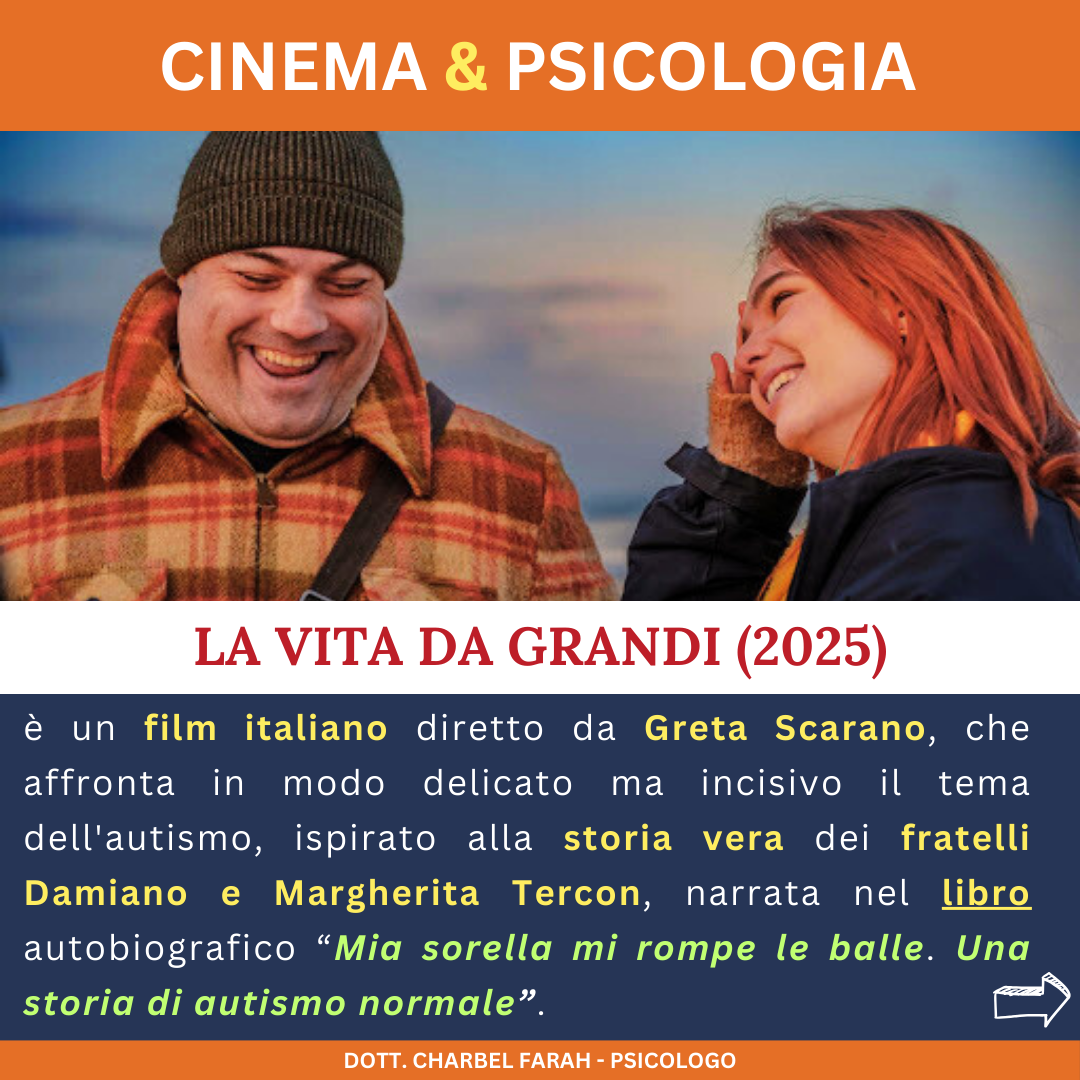
La vita da grandi è un film italiano del 2025 diretto da Greta Scarano, ispirato alla storia vera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon, narrata nel libro autobiografico Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale.
Il film affronta in modo delicato ma incisivo il tema dell'autismo, restituendo al pubblico un racconto autentico, emozionante e profondamente umano.
Prodotto da Lucky Red e Rai Cinema, rappresenta anche il debutto alla regia dell'attrice Greta Scarano, che riesce a coniugare sensibilità artistica e impegno sociale.
Trama e personaggi
La storia ruota attorno a Irene (interpretata da Matilda De Angelis), una giovane donna in carriera che vive a Roma, distante non solo fisicamente ma anche emotivamente dalla sua famiglia di origine. La sua vita prende una svolta quando la madre, sopraffatta dalle difficoltà quotidiane e soprattutto dall’esigenza di partire con il padre per sottoporsi ad alcuni accertamenti di salute in un ospedale lontano, le chiede di tornare a Rimini per occuparsi temporaneamente del fratello maggiore Omar (interpretato da Yuri Tuci), un uomo autistico di 40 anni con una grande passione per la musica rap e il sogno di diventare un artista.
Omar è un uomo con sogni, fragilità, risorse e desideri. La sua caratterizzazione si fonda su una profonda umanità e sulla complessità della condizione autistica, resa con grande realismo anche grazie al fatto che l'attore Yuri Tuci è a sua volta autistico. Questo dettaglio non solo aggiunge veridicità alla rappresentazione, ma rappresenta un importante passo avanti nella rappresentazione cinematografica della neurodivergenze, spesso affidata ad attori neurotipici.
Dal punto di vista cinematografico, La vita da grandi si muove con un ritmo riflessivo, a tratti forse fin troppo pacato. La narrazione privilegia momenti intimisti e dialoghi dilatati, il che contribuisce a restituire la profondità emotiva dei personaggi, ma può anche rischiare di rallentare il coinvolgimento dello spettatore. Alcune scene avrebbero potuto essere rese con una maggiore vivacità o dinamismo, senza perdere l'autenticità del racconto. Un tocco di leggerezza in più nella regia o nel montaggio avrebbe potuto rendere l’esperienza più accattivante, mantenendo comunque il forte impatto emotivo e il messaggio centrale della pellicola.
Riflessione psicologica
Dal punto di vista psicologico, il film esplora con grande sensibilità le dinamiche familiari che spesso si sviluppano intorno a una persona con autismo. Irene, inizialmente distante e scettica, si trova a dover fronteggiare una realtà che aveva messo da parte: la fatica, il senso di responsabilità, ma anche l'amore, la memoria e il senso di appartenenza.
Il suo percorso diventa una metafora della crescita personale: Irene non solo impara a comprendere meglio Omar, ma riesce anche a riconnettersi con la parte più autentica di sé stessa.
Il film mette in luce anche alcuni aspetti tipici dello spettro autistico:
1. Rigidità cognitiva
Omar mostra una certa difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti imprevisti. La sua quotidianità è scandita da schemi ripetitivi e consolidati: l’arrivo della sorella e il cambiamento delle abitudini rappresentano per lui una fonte di tensione e disorientamento. La rigidità cognitiva, tipica dell’autismo, emerge nei momenti in cui fatica a tollerare deviazioni dai suoi schemi, anche se minime.
2. Difficoltà nella gestione degli stimoli sensoriali
Nel film si intuiscono momenti in cui Omar è particolarmente sensibile ai suoni, alla confusione o a cambiamenti ambientali. Anche se non esplicitati in modo marcato, piccoli segnali – come il bisogno di isolarsi, il fastidio per ambienti caotici o l’eccessiva attenzione a dettagli sensoriali – suggeriscono la presenza di un’ipersensibilità sensoriale, caratteristica comune in molte persone autistiche.
3. Necessità di routine
Omar si rifugia nella prevedibilità: le sue giornate sono scandite da rituali, tempi precisi, azioni ripetute. Le routine non sono solo una forma di organizzazione, ma una strategia per sentirsi al sicuro nel mondo. Il film mostra quanto anche piccole variazioni possano generare in lui frustrazione o smarrimento.
4. Interessi ristretti
Il suo amore per il rap non è solo una passione, ma un vero e proprio centro gravitazionale della sua esistenza. L’interesse intenso e assorbente per la musica rappresenta una tipica caratteristica dello spettro: ciò che per altri può sembrare un passatempo, per Omar è un canale di espressione, identità e motivazione profonda.
5. Tendenza all’iperfocus
Questa capacità di “iperfocus” – comune nelle persone autistiche – gli permette di raggiungere livelli profondi di immersione, che nel suo caso diventano un mezzo potente per comunicare emozioni e bisogni che fatica a esprimere verbalmente in modo diretto.
Uno dei messaggi più profondi del film è l’importanza di credere nelle potenzialità delle persone autistiche, riconoscendo i loro desideri, sogni e talenti come validi e realizzabili. Piuttosto che custodirli con eccessiva protezione o, peggio, nasconderli per paura del giudizio o delle difficoltà, la storia mostra quanto sia fondamentale offrire loro fiducia, spazio e strumenti per esprimersi pienamente.
Il percorso di Omar diventa così l’emblema di quanto un ambiente che accoglie, sostiene e valorizza possa davvero fare la differenza, permettendo a chi è spesso escluso di uscire dall’invisibilità e conquistare il proprio posto nel mondo. Un altro aspetto importante riguarda la capacità di Omar di costruire relazioni significative, in particolare con la sorella.
Il legame che si rafforza nel corso della storia non è privo di conflitti, ma è autentico, fatto di momenti di rottura e riconciliazione. Questo rappresenta una sfida comune nelle famiglie con un membro autistico, dove spesso la comunicazione deve adattarsi a forme nuove, più pazienti e attente.
Un racconto tratto dalla vita reale
La forza del film risiede anche nel suo legame con la storia vera. Nella realtà, Damiano Tercon è un ragazzo autistico con una forte passione per il canto lirico e per la scrittura.
Dopo anni di esclusione e difficoltà, è riuscito a farsi conoscere partecipando, insieme alla sorella Margherita, al talent Italia’s Got Talent. Il loro legame fraterno è diventato un simbolo di solidarietà e riscatto, un esempio concreto di come l’inclusione possa partire dai legami più intimi.
Margherita, oggi coach e consulente per l'inclusione, ha dedicato parte della sua vita a raccontare la loro storia e a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'autismo.
Nel film, molti degli episodi raccontati sono trasposizioni fedeli di momenti realmente vissuti. La passione per la musica, i conflitti familiari, la difficoltà di trovare una propria voce nel mondo e, soprattutto, la scoperta del potere trasformativo dell'affetto e del riconoscimento reciproco.
Conclusioni
La vita da grandi è un film che emoziona, informa e fa riflettere. Non è solo una pellicola sull'autismo, ma una storia di crescita, di legami e di riscatto. Attraverso uno sguardo psicologicamente consapevole, il film mette al centro la persona, non la diagnosi, e ci invita a guardare oltre le etichette.
Greta Scarano firma un debutto alla regia coraggioso e ispirato, riuscendo a coniugare la narrazione cinematografica con un importante messaggio sociale. Un'opera necessaria, che parla a tutti, e che lascia il segno, nel cuore e nella mente dello spettatore.
Il mio voto per il film è 7️⃣ su 🔟
Dott. Charbel Farah - Psicologo


